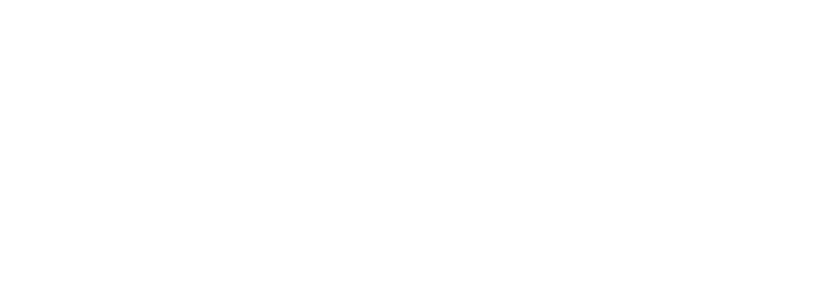La letteratura come memoria, sogno e resistenza
Dialogo tra Annalena Benini e Dacia Maraini ad Arona
Due voci femminili forti e profondamente consapevoli si sono incontrate in un dialogo che è andato oltre la letteratura, toccando la memoria, il dolore, la fede e la forzatrasformativa del racconto. Annalena Benini, scrittrice e giornalista, ha dialogato con Dacia Maraini, una delle più importanti autrici italiane, in un evento che ha avuto l’intensità di una confessione pubblica e la profondità di una lezione morale al Festival Teatro sull’Acqua 2025.
La letteratura come sogno e salvezza
Annalena Benini ha aperto l’incontro con una domanda tanto semplice quanto centrale: “Che cos’è per te la letteratura?” Per lei, la risposta è chiara: un sogno di scoperta del mondo. Dacia Maraini, con la sua consueta lucidità, ha restituito una definizione ancora più intima: “La letteratura è un piacere, non un dovere. Deve essere contagiosa. ”Un piacere che, per lei, ha avuto origine nel luogo più inaspettato: un campo di prigionia giapponese, dove, da bambina, ha vissuto per due anni tra la fame e la paura, trovando conforto nelle storie raccontate dalla madre raccontate all’ombra di un ciliegio. È lì che ha imparato il potere della narrazione, dell’affabulazione, e ha fatto il suo primo vero incontro con la letteratura. Un rifugio, una forma di sopravvivenza, un bisogno primitivo ma anche uno strumento per recuperare il linguaggio e riconnettersi al mondo. È stato grazie ai libri infatti che Dacia Maraini ha ricominciato a parlare dopo l’esperienza traumatica vissuta durante la sua infanzia.
Il male, l’infanzia e la responsabilità
Uno dei temi portanti dell’incontro è stato il concetto di male. Dacia Maraini ha condiviso una riflessione potente: se nell’antichità il male era visto come qualcosa di esterno – un demone, un’entità – nel mondo moderno abbiamo capito che il male può risiedere dentro di noi. “Serve un’azione di autocontrollo per trasformare il male in qualcosa di positivo,”afferma, sottolineando come sia necessario un rapporto dialettico e responsabile con il lato oscuro che si trova in ogni individuo. L’infanzia, per Dacia Maraini, non è il tempo spensierato che molti ricordano. Per lei è stato l’inizio della lotta. Ma proprio da quell’esperienza estrema ha tratto la forza di osservare il mondo con occhi vigili, di non ignorare mai la sofferenza, e di usare la scrittura come uno strumento di trasformazione. La paura era costante, per i bombardamenti e per le minacce dei guardiani. La fame, racconta, non solo la segnò fisicamente (in quanto si ammalò di beriberi), ma incise anche sulla sua memoria emotiva: il cibo divenne un mito, nato come tutti i miti dalla mancanza.
La bambina che parla con Dio
Durante l’incontro si è parlato anche del libro di Dacia Maraini, “La bambina che vola”, che affonda le sue radici nella fiaba e nel simbolismo. Una bambina di legno, scolpita da una donna, prende vita e inizia a parlare con Dio. Un chiaro richiamo a Pinocchio, una delle storie preferite di Dacia Maraini durante l’infanzia, ma anche un’allegoria del rapporto tra creatore e creatura, tra l’essere umano e il sacro.Il libro nasce da un progetto editoriale sui Dieci Comandamenti, e riflette sul senso della fede e della libertà. “Credere in Dio è come credere nell’amore: o ci credi o non ci credi. Ma imporre la fede è un errore.” Una posizione netta e, allo stesso tempo, aperta alla complessità dell’esperienza spirituale.
Sorellanza e memoria femminile
Annalena Benini e Dacia Maraini hanno affrontato anche il tema della sorellanza e della memoria dei rapporti femminili, troppo spesso cancellati o relegati a ruoli marginali nella narrazione storica e mitologica. La Bibbia, osserva Dacia Maraini, contiene uno dei rari esempi di amicizia femminile presenti nel mondo antico nel racconto di Ruth e della sua nuora: una testimonianza di affetto, lealtà e solidarietà tra donne. “Restituire dignità all’individualità femminile e ai rapporti salvifici tra donne è un atto necessario,” aggiunge Annalena Benini. Bisogna perseguire nel tentativo di riportare alla luce queste storie dimenticate, cercando di sanare una cancellazione culturale che è già di per sé una forma di male.
Il pericolo del consumo e della memoria digitale
Uno dei passaggi più toccanti dell’incontro è stato il racconto del ritorno di Dacia Maraini sul luogo del campo di prigionia: non c’era più nulla. Nessuna traccia. Nessun segno. Solo l’oblio. “La natura del consumo detesta la memoria,”ha detto con amarezza. Un monito che si allarga anche alla nostra epoca, dove la memoria digitale rischia di sostituire quella umana, di disinnescare il valore del ricordo condiviso. Per Dacia Maraini, è essenziale costruire una memoria collettiva che dia senso agli eventi e li sottragga alla logica del consumo, che, come diceva Pasolini, diventa devastante quando colonizza anche i rapporti umani.
Non tutti possono essere eroi: la complessità del giudizio
Nel corso del dialogo, Dacia Maraini ha offerto una riflessione lucida e profondamente umana sulla difficoltà di ribellarsi ai regimi autoritari. Ha raccontato come, al termine della guerra, scoprì che la popolazione giapponese, quella stessa tra cui aveva vissuto come prigioniera, non considerava gli italiani dei nemici. Una scoperta che le ha permesso di mantenere buoni rapporti con il Paese ma soprattutto ha inciso profondamente sul suo modo di vedere i popoli e le responsabilità individuali. “Quando un popolo è prigioniero di un regime poliziesco, la gente non può ribellarsi. Non tutti sono eroi e non si può pretenderlo” ha affermato. È un monito importante, soprattutto oggi, in tempi segnati da conflitti e divisioni ideologiche. Dacia Maraini ha invitato a no commettere l’errore di pensare che nei paesi governati da regimi autoritari, come la Russia o Israele, tutti siano d’accordo con le scelte del potere. Generalizzare significa cancellare le resistenze silenziose, le disobbedienze interiori, le vite in bilico tra paura e coraggio. È un invito a non giudicare dall’esterno, ma a comprendere la complessità delle condizioni storiche e umane. Perché il vero eroismo, a volte, non è solo nella ribellione eclatante, ma nella resistenza quotidiana, spesso invisibile, di chi cerca di preservare un frammento di dignità sotto un sistema oppressivo.
La letteratura come resistenza
Il messaggio finale, condiviso da entrambe, è forte: la letteratura è esercizio di memoria, un atto di resistenza contro l’oblio, una difesa contro il cinismo. Dacia Maraini denuncia la scarsa conoscenza della storia recente tra i giovani: “Spesso vado nelle scuole e non conoscono nulla del passato. Questo è gravissimo, significa non conoscere il periodo da cui arriviamo.” La scrittura, allora, torna ad assumere il suo compito più nobile: quello di testimoniare, educare, trasmettere.E come ha detto Annalena Benini, anche se si continuano a commettere sempre gli stessi errori, raccontarli è fondamentale. Perché solo così, forse, si potrà un giorno imparare davvero.
Fabiola Strim